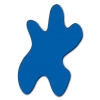(Storie dal laboratorio di scrittura autocreativa, condotto da Social.Net)

Il sole picchiava deciso quella mattina, e per di più si era scordata il cappello di paglia a casa. Come aveva potuto dimenticarselo? Ora la sottile parte di nuca esposta al sole, tra i folti, mossi, lunghi capelli neri, le bruciava da morire. Pazienza, avrebbe messo la crema una volta tornata a casa. Sentiva le risate dei ragazzi e delle ragazze in riva al mare, il loro schizzarsi a vicenda, il prendersi sulle spalle e gettarsi in acqua in capriole leggiadre, la spuma delle onde infrangersi sulle loro caviglie scure e coperte di braccialetti di stoffa. Una nota fitta di invidia la colpì in pieno petto, anche se cercò di cacciarla via così come era arrivata.
Catherine si alzò traballante, raccolse da terra il suo asciugamano con fantasia a fenicotteri, se lo ficcò nella borsa di paglia e decise di tornare a casa. Scese lentamente per l’unico sentiero che collegava l’isola da una costa all’altra, per raggiungere il villaggio. Chiamarlo villaggio forse era esagerato, si trattava di un pugno di capanne costruite in una spaziosa conca all’interno della piccola isola di Zahnia, ma gli abitanti ne andavano molto fieri e l’avevano battezzato “Villaggio di Zahnia”. Mentre camminava pensierosa, Catherine calciava distrattamente alcuni piccoli sassi che si imbattevano davanti a lei. A quei ragazzi non era accaduto nulla, mentre a lei sì. Perchè a loro no e a lei sì? Aveva forse fatto qualcosa per meritarsi quello che le era successo? Qualche errore in una vita passata forse?
“Buongiorno, Catherine” la salutò cordialmente un piccolo ometto calvo, che la giovane riconobbe subito come il bottegaio del paese. “Una gita al mare?” aggiunse subito, notando la borsa di paglia che portava sulla spalla destra. “Sì” rispose lei con un mezzo sorriso, ancora assorta nei suoi pensieri. Lui era gentile, certo. Ma non poteva capire. Nessuno in quel piccolo, stupido villaggio poteva capire. Sentì la rabbia montare lentamente nel petto, salutò l’uomo con la mano e corse via. Una volta arrivata nella sua capanna, lanciò la borsa sul letto, si sedette in una vecchia poltroncina consunta e si sfilò la protesi dalla gamba sinistra. Restò sospesa nei suoi pensieri per quasi mezz’ora. Le capitava spesso di ripensare al giorno dell’incidente, ma per quanto si impegnasse, per quanto si spremesse le meningi, non ricordava nulla di quel piovoso giovedì di 25 anni prima. “Non è successo nulla di che” le aveva raccontato la madre “eri una bambina scalmanata, disubbidiente. Ti abbiamo perso di vista un attimo e… e ti abbiamo ripreso sotto un carro trasportato da un asino che passava per caso in quel momento sul sentiero.” E ancora, amava rincarare la dose “Io ho avuto sensi di colpa per quello che è successo. Ti rendi conto di come mi hai rovinato la vita?”. Buffo, pensava Catherine, come ognuno di noi si crei una realtà che lo fa sentire sicuro, nel giusto, una realtà facile, travisata. Aveva smesso di cercare di farsi capire, di far capire agli altri come si sentiva, con una gamba amputata quasi completamente a soli 3 anni e mezzo. Era la storia della sua vita, non essere compresa profondamente, sentirsi sola, isolata, diversa.
L’orologio della cucina scoccò il mezzogiorno. “Sono in ritardo” pensò Catherine, che si risistemò la gamba alla bell’e meglio e cominciò a prepararsi un pranzo veloce. All’una e mezza sarebbero arrivati i piccolini, i bambini di età compresa tra i due e i cinque anni, in uno squallido edificio rettangolare al centro del villaggio, con un cortile esterno in cui scorrazzavano galline e polli. Lei era, per così dire, la loro maestra, anche se non aveva alcuna qualifica, ma a quanto pareva nel villaggio non ne era richiesta alcuna.
Amava il suo lavoro, e probabilmente era l’unica cosa che la teneva ancora al villaggio. Gli sguardi sinceri, i sorrisi inaspettati, la gioia dei piccoli le riempivano il cuore di felicità e la facevano sentire al posto giusto, adeguata.
I primi 28 anni della vita di Catherine si erano srotolati in questa routine un po’ monotona, ma che la rendeva serena. Casa, scuola, mare, mare ,casa, scuola. Certo, non aveva amici, per scelta sua, pensava che il peso di quello che le era capitato fosse qualcosa che doveva portare da sola nel mondo. Non era nemmeno in pace con sè stessa, né tantomeno con la sua famiglia, che evitava accuratamente da parecchi anni. Si voleva bastare per quello che era, ma non ci riusciva. Non si piaceva, no. A nulla erano serviti gli apprezzamenti dei ragazzi dell’isola, sul suo fisico asciutto, la pelle dorata, i capelli lucidi e il seno tornito. Nulla le avrebbe fatto cambiare idea, ne era convinta.
Ma proprio quando si pensa di essere giunti al capolinea, o comunque si pensa che non accadrà più nulla degno di nota, la vita meravigliosamente ci sorprende, ci prende alla sprovvista e ci illumina gli occhi di nuova luce.
Quella mattina Catherine si era svegliata di malumore, dopo un sonno un po’ agitato. Il suo gatto Pedro, una piccola tigre arancione che aveva salvato dal porto dell’isola e adottato a tempo indeterminato, era acciambellato dolcemente in fondo al letto. Pedro le aveva insegnato che per ricevere amore, non è necessario amare a propria volta, ma basta essere disposti a lasciarsi amare. Questo già aveva smosso qualcosa dentro di lei, ma non capiva che cosa. Tutto quello che sapeva, era che amava quel gatto quanto la sua stessa vita, e che non lo avrebbe mai lasciato.
Si preparò del caffè nero lungo e qualche rimasuglio di pesce dalla sera prima per Pedro, che si strofinava il muso sulle sue gambe, per essere nutrito. Quando uscì per recarsi alla scuola, Catherine si rese conto che piovigginava, così tirò fuori dall’armadio un impermeabile un po’ consunto e si premette il cappuccio sulla nuca. Aveva appena fatto pochi passi, quando vide una folla di persone sciamare da ogni parte del villaggio verso l’ospedale, un vecchio edificio scolorito e fatiscente, che si ergeva su una collinetta a un centinaio di metri dal centro. Ci risiamo, un altro morto, pensò subito lei, che ormai era abituata a quella sanità malconcia, l’unica che l’isola potesse permettersi e l’unica che lei avesse mai conosciuto. Fu vinta dalla curiosità e si inerpicò anche lei su per lo stretto sentiero che portava all’ospedale.
“Ma che è successo?” chiese a un pescatore accorso dalla sua barca ormeggiata alla banchina. “Si tratta della giovane coppia Jardin” si affrettò a replicare “La moglie, che era incinta, ha partorito una bambina…be, non so spiegare, vedrai con i tuoi occhi”. La curiosità di Catherine balzò alle stelle. Una bambina come? Senza una gamba come lei? Cieca? Sorda? Non sapeva cosa pensare.
Ma quello che vide poco dopo, la ferì profondamente. I coniugi Jardin, al cui matrimonio lei aveva partecipato, stavano scendendo giù per la stradina a tutta velocità, la donna ancora sanguinante e in lacrime, il marito chiaramente rosso per la vergogna e per l’imbarazzo. Non ci poteva credere. Non ci voleva credere. Si fece largo nella folla, e ciò che vide fu qualcosa che non avrebbe mai più dimenticato. Una neonata di poche ore, ancora tutta arrossata, con folti capelli castani, osservava da dietro il vetro gli ansanti, in una culla di vimini imbottita di calde coperte bianche. Aveva grandi occhi nocciola a mandorla e un adorabile nasino all’insù. Catherine capì all’istante che per quella famiglia probabilmente, la nascita di una bambina down rappresentava una sconfitta, una onta, qualcosa da nascondere. Si sentì avvampare di rabbia e di frustrazione, quella piccola non aveva ancora esalato il primo respiro e già non veniva accettata e amata per quello che era. Era un piccolo essere innocente, non aveva fatto nulla di male, eppure così tanto male le era già stato fatto.
Ma non capivano? Era meravigliosa. Quella sua disabilità la rendeva ancora più bisognosa di amore, di essere accudita e cresciuta. Era una ricchezza inestimabile per i suoi genitori, che però si erano solo fermati sulla superficie di una pozzanghera sporca, che dentro nascondeva un piccolo giocattolo colorato, dimenticato da chissà quale bambino.
Quello stesso pomeriggio, Catherine si recò nell’ufficio municipale del paese e adottò Camille.
Due anni dopo, all’età di 30 anni, Catherine non poteva essere più felice. Faceva sempre la maestra d’asilo, aveva adottato un altro micino oltre a Pedro, Coco. Aveva incominciato a frequentare qualche ragazza e qualche ragazzo, in amicizia, e si era resa conto che nessuno la giudicava per la sua gamba finta o per l’incidente. La amavano e apprezzavano per la persona che era, per i valori in cui credeva, per i tratti del suo carattere che nemmeno lei conosceva bene. Aveva sempre guardato gli altri da dietro il buco della serratura, ma ora che aveva aperto la porta, non era poi tanto male.
Aveva scoperto la gioia di essere mamma. Mamma di una bimba che aveva scelto, mamma di una bimba disabile che le insegnava ogni giorno cosa significa dare e ricevere amore. Non doveva sentirsi adeguata o brava in quello che faceva, perchè Camille la faceva sentire perfetta così come era. Le aveva insegnato tantissimo, tanto che a volte Catherine pensava di essere lei la bambina che doveva imparare.
Sicuramente, la cosa più importante che le aveva insegnato Camille è che la vita è difficile soltanto nella misura in cui noi le permettiamo di esserlo.